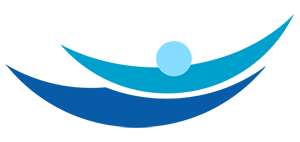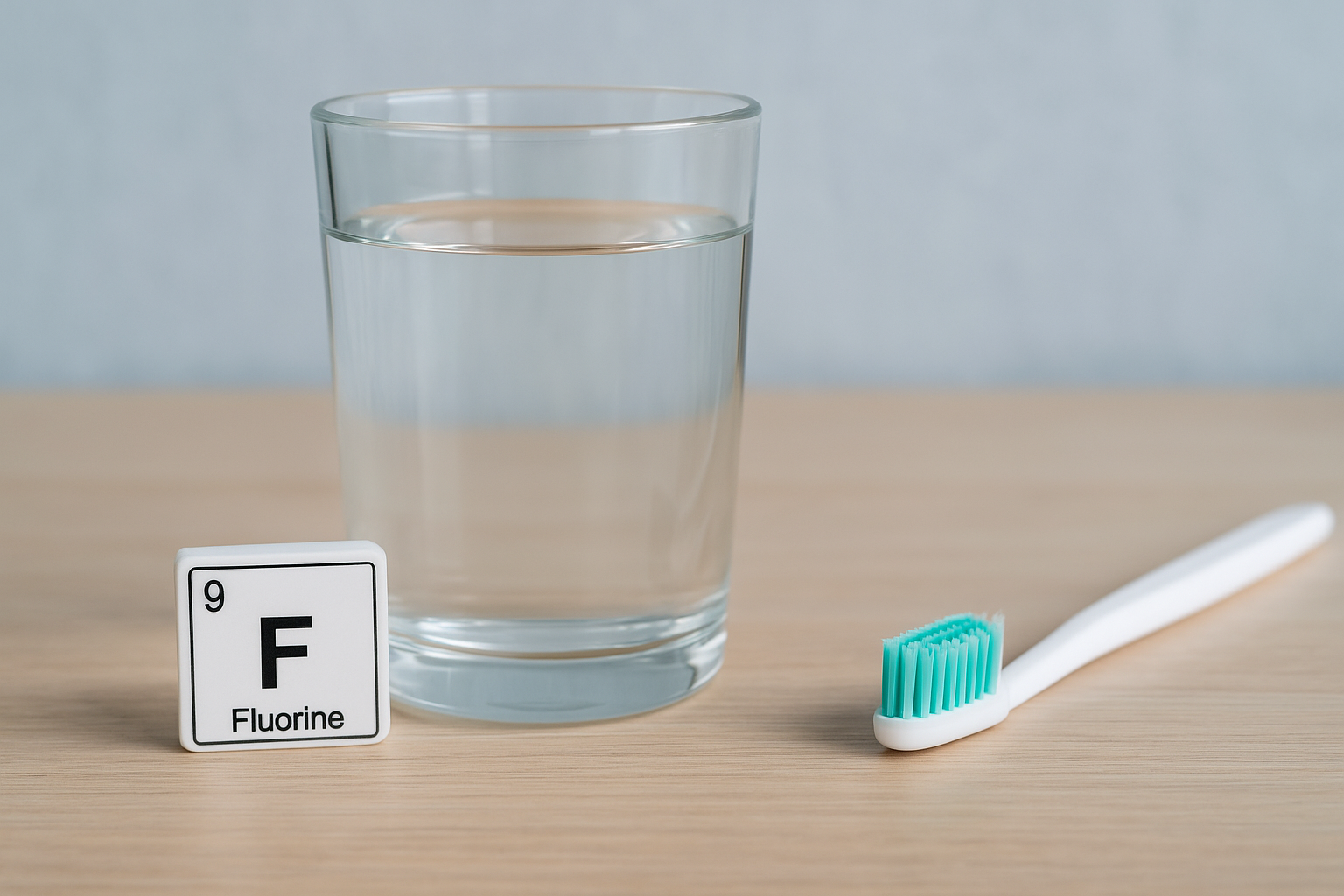
Il fluoro è uno degli elementi più discussi quando si parla di qualità dell’acqua potabile. Per alcuni è un prezioso alleato nella prevenzione della carie dentale, per altri un potenziale pericolo per la salute se presente in quantità eccessive.
Come spesso accade in chimica e in biologia, è la dose a fare la differenza tra cura e rischio.
Nell’acqua potabile, il fluoro è presente sotto forma di fluoruri (ioni F⁻), naturali o aggiunti artificialmente, e il suo ruolo varia a seconda della concentrazione, della popolazione esposta e delle condizioni ambientali.
Capire come si comporta, da dove proviene e quali effetti esercita sull’organismo è fondamentale per gestire l’acqua in modo sicuro e consapevole.
1. Che cosa sono i fluoruri
I fluoruri sono sali dell’acido fluoridrico (HF), in cui lo ione fluoruro è legato a metalli alcalini o alcalino-terrosi (come calcio o sodio).
In natura, il fluoro è molto diffuso: si trova nelle rocce (fluorite, criolite, apatite), nel suolo e in piccole quantità nell’atmosfera e nelle acque sotterranee.
Quando le falde attraversano terreni ricchi di minerali fluorurati, l’acqua ne assorbe quantità variabili che, in alcuni casi, possono risultare elevate.
In Italia, la presenza di fluoruri nelle acque naturali varia in modo significativo:
- basse concentrazioni (< 0,3 mg/L) in zone di pianura o su terreni silicei;
- valori medi (0,3–1,0 mg/L) in aree vulcaniche o calcaree;
- valori elevati (> 1,5 mg/L) in alcune aree del Lazio, Campania, Toscana e Sardegna, dove l’origine è esclusivamente geogenica, cioè naturale.
2. Benefici a basse concentrazioni
Il fluoro, in quantità controllate, svolge un ruolo benefico importante:
favorisce la mineralizzazione dei denti e contribuisce alla prevenzione della carie.
L’effetto protettivo si deve alla sua capacità di:
- sostituire parzialmente l’idrossile nell’idrossiapatite dello smalto dentale, formando fluoroapatite, un composto più resistente all’attacco acido dei batteri;
- ridurre la demineralizzazione e favorire la remineralizzazione precoce dello smalto.
Questo meccanismo è stato scoperto negli anni ’40, quando si osservò che popolazioni che bevevano acqua contenente 0,7–1,0 mg/L di fluoro presentavano una minore incidenza di carie dentale rispetto ad altre.
Per questo motivo, in alcuni Paesi (soprattutto Stati Uniti, Regno Unito, Irlanda, Australia) si pratica ancora oggi la fluorurazione controllata dell’acqua, aggiungendo sali fluorurati per raggiungere concentrazioni preventive ottimali.
In Italia e in gran parte dell’Europa, invece, tale pratica non è adottata, preferendo l’uso di dentifrici e prodotti topici fluorurati per ridurre il rischio di esposizioni eccessive.
3. I rischi dell’eccesso di fluoro
Come ogni elemento utile all’organismo, anche il fluoro può diventare tossico oltre una certa soglia.
L’assunzione cronica di quantità elevate porta alla fluorosi, una condizione che colpisce prima lo smalto dei denti e, nei casi più gravi, anche le ossa.
3.1. Fluorosi dentale
È la forma più comune e si manifesta durante lo sviluppo dei denti permanenti, in età infantile.
L’eccesso di fluoro interferisce con la formazione dello smalto, causando macchie biancastre o brunastre e, nei casi severi, fragilità dentale.
Compare con concentrazioni superiori a 1,5 mg/L di fluoro nell’acqua assunta per periodi prolungati.
3.2. Fluorosi scheletrica
È una forma più rara e grave, tipica di regioni con elevata presenza naturale di fluoro (come India, Cina, alcune zone africane).
L’accumulo di fluoruri nelle ossa può causare indurimento, dolore articolare e rigidità fino a deformazioni scheletriche.
Si manifesta con esposizioni croniche a valori superiori a 4–5 mg/L.
3.3. Effetti sistemici e vulnerabilità
L’assorbimento di fluoro dipende da vari fattori: età, dieta, stato di salute renale e assunzione di calcio e magnesio.
Nei bambini e nei soggetti con insufficienza renale, la capacità di eliminazione è ridotta, aumentando il rischio di accumulo.
4. Limiti normativi e valori guida
La normativa italiana, europea e internazionale stabilisce limiti molto precisi per i fluoruri, bilanciando sicurezza e beneficio:
| Riferimento normativo | Parametro | Valore massimo ammissibile (mg/L) |
| Direttiva (UE) 2020/2184 – D.Lgs. 18/2023 | Fluoruri (F⁻) | 1,5 |
| WHO – Guidelines for Drinking-water Quality (2022) | Fluoruri (F⁻) | 1,5 |
| EPA – National Primary Drinking Water Regulations | Fluoruri (F⁻) | 4,0 (valore massimo consentito), 2,0 (livello raccomandato) |
In Italia, il limite di 1,5 mg/L è considerato il punto di equilibrio tra protezione dentale e prevenzione della fluorosi.
Oltre questo valore, l’acqua non è considerata idonea al consumo umano continuativo.
5. Monitoraggio e trattamento
I gestori idrici sono tenuti a controllare regolarmente la concentrazione di fluoruri in tutte le acque destinate al consumo umano.
Nelle zone con concentrazioni naturali elevate, le autorità sanitarie possono:
- imporre limitazioni d’uso (es. evitare consumo prolungato nei bambini);
- raccomandare fonti alternative di approvvigionamento;
- attivare sistemi di trattamento mirati alla riduzione dei fluoruri.
Tecniche di rimozione
Poiché i fluoruri sono stabili e solubili, la loro rimozione richiede trattamenti specifici:
- Osmosi inversa: metodo più efficace, adatto anche su piccole reti.
- Adsorbimento su allumina attivata o carboni specifici.
- Scambio ionico con resine anioniche.
- Coagulazione con sali di alluminio (efficace ma usata meno frequentemente).
Queste tecnologie devono essere gestite in modo controllato, perché possono alterare anche altri parametri dell’acqua (pH, salinità, contenuto minerale).
6. Aspetti biologici e ambientali
Il fluoro non è solo un parametro sanitario, ma anche un indicatore geochimico.
In molte aree vulcaniche o geotermiche, la sua presenza è legata all’attività magmatica, e varia naturalmente nel tempo.
Tuttavia, esistono anche fonti antropiche, come:
- industrie del vetro, dell’alluminio e dei fertilizzanti;
- scarichi industriali non controllati;
- emissioni atmosferiche di fluoruri che si depositano nel suolo e raggiungono le falde.
A livello ecotossicologico, concentrazioni elevate di fluoro possono danneggiare la fauna acquatica, interferendo con i processi metabolici di pesci e anfibi.
Per questo motivo, anche gli standard ambientali per le acque superficiali fissano limiti severi (in genere 0,5–1,0 mg/L) per proteggere gli ecosistemi.
7. Il bilancio tra beneficio e rischio
Parlare di fluoro nell’acqua significa parlare di equilibrio.
Un deficit può favorire la carie, un eccesso può provocare fluorosi.
L’unico modo per garantire sicurezza è mantenere un controllo continuo, supportato da analisi, trasparenza e informazione ai cittadini.
Le autorità sanitarie raccomandano di:
- evitare l’assunzione combinata di acque fluorurate e integratori o dentifrici ad alto contenuto di fluoro nei bambini piccoli;
- scegliere acque minerali con meno di 0,5 mg/L di fluoro in età pediatrica;
- garantire che ogni fonte pubblica sia monitorata e dichiarata in etichetta.
8. Conclusione
Il fluoro è un alleato prezioso, ma come ogni strumento di prevenzione richiede misura e conoscenza.
Nell’acqua potabile rappresenta una soglia di equilibrio sottile tra beneficio e rischio.
Rispettare i limiti normativi, informare correttamente la popolazione e adottare tecnologie di controllo efficaci significa preservare la salute senza rinunciare alla qualità.
L’acqua, come sempre, ci ricorda che la sicurezza non si misura solo in milligrammi per litro, ma nella capacità di gestire con intelligenza ciò che la natura ci offre.
Riferimenti normativi e scientifici
- Direttiva (UE) 2020/2184 – Acque destinate al consumo umano
- D.Lgs. 18/2023
- WHO, Guidelines for Drinking-water Quality, 2022
- EPA, National Primary Drinking Water Regulations, 2021
- EFSA, Scientific Opinion on Dietary Fluoride Intake in EU Population, 2023
- ISS, Linee guida sulla qualità delle acque potabili e i parametri chimici di sicurezza, 2024