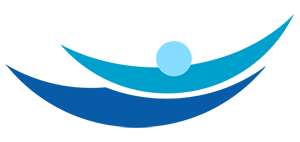Principi scientifici e quadro normativo italiano
1. Introduzione
Bere acqua sicura non è un fatto scontato.
Dietro il semplice gesto di aprire un rubinetto c’è un complesso lavoro di monitoraggio, valutazione e controllo.
La qualità dell’acqua potabile è regolata da leggi precise che stabiliscono quali sostanze vanno controllate (parametri) e qual è il loro livello massimo accettabile (limiti).
Questi valori non vengono scelti “a caso”: sono il risultato di studi scientifici e di valutazioni che tengono conto di diversi aspetti, tra cui:
- i possibili effetti tossici o cancerogeni delle sostanze;
- la somma dell’esposizione nel tempo (non solo un bicchiere, ma tutta la vita);
- le ricerche epidemiologiche sulle popolazioni;
- i rischi specifici per le persone più vulnerabili, come bambini, anziani o immunodepressi;
- la capacità tecnica dei sistemi di trattamento dell’acqua;
- la sostenibilità economica delle misure di controllo.
In Italia il quadro legislativo si basa principalmente su:
- la Direttiva (UE) 2020/2184, valida per tutti gli Stati membri;
- il Decreto Legislativo 18/2023, successivamente aggiornato e migliorato dal D.Lgs. 102/2025.
2. Il quadro normativo attuale
2.1 Direttiva (UE) 2020/2184
Ha ridisegnato la normativa europea con tre obiettivi principali:
- garantire un alto livello di protezione della salute umana;
- affrontare contaminanti emergenti come microplastiche e PFAS;
- introdurre un approccio basato sul rischio con i Piani di Sicurezza dell’Acqua (PSA).
2.2 Decreto Legislativo 18/2023
Ha recepito la direttiva europea introducendo importanti novità:
- nuove categorie di sostanze da monitorare (farmaci, microplastiche, sostanze emergenti);
- obbligo di valutare il rischio lungo tutta la filiera, dalla captazione al rubinetto;
- maggiore trasparenza e comunicazione verso i consumatori.
2.3 Decreto Legislativo 102/2025
Rappresenta il passo più recente e innovativo. Ha introdotto:
- limiti più severi per i PFAS e altre sostanze chimiche persistenti;
- controlli più rigidi sui materiali che entrano in contatto con l’acqua (MOCA), con il sistema ReMaF;
- obblighi di autocontrollo più stringenti per scuole, ospedali e altre strutture “sensibili”;
- la creazione della banca dati nazionale AnTeA, gestita dall’ISS tramite il CeNSiA.
3. Come vengono scelti i parametri
Non tutte le sostanze presenti nell’ambiente entrano automaticamente nelle liste di controllo.
I parametri da monitorare sono selezionati in base a:
- documentato rischio sanitario (es. microbi patogeni, piombo, arsenico);
- frequente presenza nell’ambiente (es. pesticidi, PFAS);
- disponibilità di evidenze tossicologiche ed epidemiologiche;
- possibilità reale di analizzarli con strumenti affidabili;
- linee guida di organismi internazionali come OMS, EFSA o US EPA.
4. Come si fissano i limiti
4.1 I valori di riferimento
La base scientifica è la “dose soglia” oltre la quale una sostanza può causare effetti dannosi.
Alcuni indicatori usati sono:
| Valore | Significato |
|---|---|
| ADI (Acceptable Daily Intake) | Quantità di sostanza che si può assumere ogni giorno per tutta la vita senza rischi significativi |
| TDI (Tolerable Daily Intake) | Dose tollerabile, usata per sostanze presenti nell’ambiente |
| NOAEL/LOAEL | Dose senza effetti osservati / dose più bassa con effetti osservati |
| BMDL | Dose derivata da curve dose-risposta (modelli statistici) |
4.2 La formula semplificata
Per tradurre questi valori in un limite per l’acqua, si usa una formula che considera:
- peso corporeo medio;
- quantità d’acqua bevuta ogni giorno;
- percentuale di esposizione attribuita all’acqua.
Esempio:
Se il TDI è 0,0005 mg/kg/giorno, per una persona di 70 kg che beve 2 litri d’acqua al giorno e attribuendo all’acqua il 20% dell’esposizione, il limite calcolato è 3,5 µg/L.
4.3 Fattori di sicurezza
Per essere prudenti, i limiti vengono abbassati applicando “margini di sicurezza” che coprono:
- differenze tra animali e uomo;
- variabilità individuale;
- mancanza di dati sufficienti;
- possibili effetti combinati con altre sostanze.
5. Alcuni esempi concreti
- PFAS: sostanze chimiche persistenti, usate in impermeabilizzanti e schiume antincendio.
Sono bioaccumulabili e possono danneggiare fegato e sistema immunitario.
Dal 2026 il limite in Italia è di 0,10 µg/L (somma dei principali PFAS). - Piombo: metallo pesante neurotossico, pericoloso soprattutto per i bambini.
Il limite è stato abbassato a 5 µg/L. - Nitrati: presenti soprattutto in aree agricole. Possono causare metaemoglobinemia nei neonati. Limite: 50 mg/L.
6. L’approccio integrato al rischio
La normativa europea e italiana non si limita più a stabilire “quanto c’è dentro l’acqua”, ma chiede anche di analizzare “come l’acqua arriva al rubinetto”.
Per questo sono stati introdotti i Piani di Sicurezza dell’Acqua (PSA), che richiedono:
- valutazione preventiva di ogni fase del sistema idrico (captazione, trattamento, distribuzione, impianti interni);
- monitoraggio dei contaminanti emergenti;
- analisi delle interazioni tra sostanze (effetti sinergici).
7. Conclusioni
Definire i parametri e i limiti dell’acqua potabile è un lavoro che unisce scienza, salute pubblica e tecnologia.
Non si tratta solo di numeri su una tabella, ma di un processo che:
- valuta rischi sanitari sulla base di studi epidemiologici e tossicologici;
- integra considerazioni tecniche ed economiche;
- si aggiorna costantemente con le nuove scoperte scientifiche.
Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 102/2025, l’Italia si è allineata alle migliori pratiche europee, con regole più severe e strumenti di controllo avanzati.
L’obiettivo è semplice ma fondamentale: assicurare a tutti un’acqua davvero sicura e di qualità.