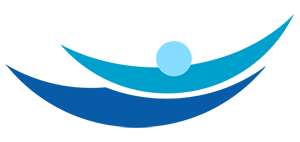Perdite, qualità e sicurezza dell’acqua potabile in Italia
Introduzione
Ogni giorno, milioni di metri cubi d’acqua vengono immessi nelle reti idriche urbane italiane per arrivare nelle nostre case, scuole, ospedali e industrie.
Eppure, quasi la metà di quest’acqua non ci arriva mai. Secondo i dati ufficiali ISTAT e ARERA, il 42% dell’acqua potabile distribuita in Italia viene dispersa lungo la rete, perduta tra vecchie condotte, perdite occulte, rotture e inefficienze strutturali.
Un dato impressionante, che colloca il nostro Paese tra i peggiori in Europa per efficienza della distribuzione idrica. Ma dietro a questa cifra non si nasconde solo uno spreco economico: ci sono anche problemi di qualità, sicurezza igienica e affidabilità del servizio, che impongono un cambio di mentalità nella gestione delle infrastrutture idriche urbane.
1. La rete idrica urbana: un sistema complesso e vulnerabile
La rete idrica è una delle infrastrutture più estese e invisibili di una città.
Sotto le strade e i marciapiedi si snodano migliaia di chilometri di tubazioni, spesso installate decenni fa, in materiali ormai obsoleti (ghisa grigia, cemento-amianto, acciaio, PVC rigido).
In molte città italiane, oltre il 60% delle reti ha più di 40 anni di età e in alcuni casi addirittura più di mezzo secolo.
Le conseguenze sono evidenti:
- Perdite costanti e difficili da localizzare.
- Pressioni instabili, che generano richiamo di impurità o aria nei tratti depressurizzati.
- Rischi microbiologici dovuti a stagnazioni o infiltrazioni da terreno.
Le condotte non sono semplici “tubi”: sono sistemi dinamici, soggetti a variazioni di pressione, vibrazioni, corrosione, temperatura, sedimentazione e biofilm batterico.
2. Le cause della dispersione idrica
Il dato del 42% di perdite (media nazionale, fonte ISTAT 2023) è il risultato di una combinazione di fattori:
- Invecchiamento delle reti: materiali deteriorati, giunti logori, corrosione interna.
- Scarsa manutenzione programmata: molti gestori intervengono solo in caso di guasto, non in prevenzione.
- Mancanza di distrettualizzazione e monitoraggio: assenza di sistemi di telecontrollo e misurazione continua.
- Prelievi non autorizzati e connessioni abusive.
- Perdite occulte: piccole ma costanti, difficili da individuare.
In termini assoluti, questo significa che su 100 litri d’acqua potabile immessi nella rete, circa 42 si disperdono prima di arrivare al rubinetto.
È come se quasi una città su due rimanesse senza approvvigionamento.
3. Impatto sulla qualità dell’acqua potabile
La dispersione non comporta solo spreco idrico, ma influenza direttamente la qualità microbiologica e chimica dell’acqua di rete.
Ogni perdita rappresenta un punto di vulnerabilità che può favorire:
- Ingressi di contaminanti da suolo e falda (acque superficiali, terriccio, reflui, gas).
- Formazione di biofilm batterici interni alle condotte.
- Stagnazioni e variazioni di cloro residuo, con perdita del potere disinfettante.
Queste condizioni, unite all’assenza di manutenzione periodica, possono creare un ambiente favorevole alla ricrescita microbica, inclusa la Legionella spp., soprattutto nei tratti terminali e nei serbatoi.
4. L’importanza delle analisi periodiche e della sorveglianza
Il D.Lgs. 18/2023 (recepimento della Direttiva (UE) 2020/2184) ed il successivo D.Lgs. 102/2025, impongono controlli regolari sulla qualità dell’acqua destinata al consumo umano.
Gli enti gestori devono eseguire campionamenti e analisi chimico-microbiologiche rappresentative lungo tutta la rete di distribuzione.
Parametri di controllo principali:
- Microbiologici: Escherichia coli, enterococchi, coliformi, pseudomonadi, Legionella (nei punti critici).
- Chimici: metalli, nitrati, cloriti, trialometani, PFAS, arsenico, residuo fisso.
- Indicatori: pH, torbidità, conduttività, cloro residuo, temperatura.
Oltre ai controlli obbligatori, è buona pratica eseguire analisi interne aggiuntive nei punti sensibili: scuole, ospedali, alberghi, edifici pubblici, strutture sanitarie e ricettive.
Solo una sorveglianza continua consente di prevenire e individuare tempestivamente alterazioni o rischi.
5. Igienizzazione idrica: un intervento necessario
Nei tratti di rete o negli impianti interni in cui si rilevano presenze microbiche anomale o situazioni di stagnazione, la sanificazione e disinfezione idrica diventano indispensabili.
Tecniche principali:
- Disinfezione chimica: dosaggio controllato di ipoclorito di sodio o biossido di cloro, rispettando i limiti previsti dal D.Lgs. 18/2023 (valore guida: 0,2–0,5 mg/L di cloro residuo libero), o altri prodotti presidio medico chirurgici più specifici e con azione a largo spettro.
- Igienizzazione shock: trattamento temporaneo con concentrazioni superiori, seguito da risciacquo e verifica analitica.
- Disinfezione fisica: sistemi a raggi UV o ozono, efficaci per eliminare microrganismi senza residui chimici.
- Pulizia dei serbatoi e risanamento delle reti: rimozione di sedimenti, biofilm e depositi.
Un piano di igienizzazione periodica, integrato con un programma di monitoraggio analitico, è lo strumento più efficace per garantire la sicurezza dell’acqua potabile, specialmente negli impianti con lunga permanenza dell’acqua.
6. Quadro normativo e responsabilità
Il sistema normativo italiano si basa oggi su tre pilastri:
- Direttiva (UE) 2020/2184 – nuova impostazione preventiva e basata sul rischio, introduzione dei Piani di Sicurezza dell’Acqua (PSA).
- D.Lgs. 18/2023 – recepimento italiano della direttiva, con revisione dei parametri e obblighi di trasparenza verso l’utenza.
- D.Lgs. 102/2025 – integrazioni tecniche e chiarimenti sui ruoli gestori, autorità sanitarie e enti di controllo.
Tali norme obbligano i gestori e i responsabili delle reti a:
- Mantenere la rete in stato di efficienza e igiene.
- Attuare un sistema di monitoraggio continuo.
- Comunicare tempestivamente eventuali superamenti dei limiti.
- Garantire la sicurezza sanitaria lungo l’intera filiera, dal pozzo al rubinetto.
7. La questione delle perdite: un problema anche ambientale ed economico
Il 42% di acqua dispersa non è solo un dato tecnico: rappresenta un fallimento economico e ambientale.
Significa sprecare:
- Energia elettrica usata per pompaggio e potabilizzazione.
- Prodotti chimici utilizzati nel trattamento.
- Risorse pubbliche per un bene che non raggiunge il cittadino.
Ogni litro perso è un litro trattato e disinfettato inutilmente, con conseguente aggravio di costi e aumento delle emissioni di CO₂.
In un contesto di cambiamenti climatici e siccità ricorrenti, questa inefficienza è semplicemente insostenibile.
8. Verso una gestione moderna e sostenibile
Ridurre le perdite e migliorare la sicurezza idrica richiede tecnologia, pianificazione e cultura del controllo.
Le soluzioni oggi disponibili includono:
- Telecontrollo e sensori IoT per la localizzazione automatica delle perdite.
- Distrettualizzazione delle reti (DMA) per monitoraggio mirato.
- Analisi predittiva dei guasti con algoritmi basati su dati storici.
- Piani di manutenzione preventiva e campagne periodiche di igienizzazione.
Ma soprattutto, serve una visione strategica integrata che unisca la qualità dell’acqua, la sicurezza sanitaria e l’efficienza infrastrutturale.
Conclusioni
L’acqua potabile che esce dai nostri rubinetti è il risultato di un percorso complesso e delicato.
Quando una rete perde il 42% del suo contenuto, non si tratta solo di una perdita fisica, ma anche di una perdita di fiducia e di sicurezza.
Garantire acqua sicura significa manutenere, controllare e igienizzare.
Solo investendo in reti più moderne, analisi regolari e piani di sicurezza efficaci, l’acqua potrà continuare a essere ciò che deve essere: un diritto universale, sicuro e sostenibile.
Riferimenti
- ISTAT, Censimento acque per uso civile, 2023.
- ARERA, Relazione annuale 2024 sulla qualità del servizio idrico integrato.
- Direttiva (UE) 2020/2184.
- D.Lgs. 18/2023 e D.Lgs. 102/2025.
- WHO, Guidelines for Drinking-water Quality, 4ª edizione.
- Istituto Superiore di Sanità, Linee guida per la gestione delle reti idriche e la prevenzione microbiologica.