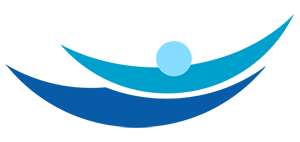Molti bagnanti notano, soprattutto in alcune giornate, piccoli puntini bianchi che costellano la superficie dell’acqua.
Con il tempo, questi puntini si aggregano fino a formare una schiuma densa e persistente, che rimane sia in mare sia sulla battigia.
La domanda è inevitabile: è un fenomeno naturale oppure c’è di mezzo l’inquinamento?La risposta richiede di capire cosa succede alla superficie del mare quando aria, acqua e sostanze disciolte interagiscono.
Come si forma la schiuma marina: la base scientifica
La schiuma è il risultato della stabilizzazione di bolle d’aria nella parte più superficiale dell’acqua. In condizioni normali le bolle collassano rapidamente, ma quando nell’acqua sono presenti sostanze tensioattive che riducono la tensione superficiale, le pareti delle bolle diventano più stabili e la schiuma persiste.
All’origine di questa stabilità ci sono soprattutto tensioattivi naturali: composti organici (proteine, lipidi, polisaccaridi, acidi umici, esopolisaccaridi microbici/EPS) rilasciati da fitoplancton, alghe e microrganismi o derivati dalla decomposizione di materiale biologico.
Il moto ondoso fornisce l’energia meccanica che mescola aria e acqua; le microbolle (i “puntini bianchi”) si formano, si addensano e infine coalescono in schiume sempre più compatte.
Tre fattori ambientali modulano il fenomeno:
- Idrodinamica: risacca, vento e frangenti aumentano l’inglobamento d’aria e la miscelazione.
- Salinità e temperatura: influenzano la viscosità e il comportamento dei tensioattivi naturali; acque più fredde e ricche di materia organica disciolta spesso favoriscono schiume più longeve.
- Stagionalità biologica: durante fioriture algali e periodi di elevata produttività biologica, la concentrazione di tensioattivi naturali cresce e la schiuma è più probabile.
Questo spiega perché, in assenza di odori o colorazioni anomale, la schiuma può essere del tutto naturale.
È lo stesso principio dei protein skimmer negli acquari marini: si sfrutta la tendenza delle sostanze organiche a “schiumare” per rimuoverle.
Quando preoccuparsi: schiuma naturale vs schiuma da sorgenti antropiche
La schiuma naturale si riconosce in genere da:
- Colore: bianco, bianco-beige o leggermente bruno per il materiale organico; aspetto opaco, non “brillante”.
- Odore: neutro o “marino”, talvolta lievemente organico ma non sgradevole.
- Comportamento: si forma in prossimità di scogliere e zone di forte risacca; può accumularsi in strisce e chiazze, ma tende a disperdersi con il variare del moto ondoso.
- Contesto: assenza di rifiuti galleggianti associati; acqua per il resto limpida o solo moderatamente torbida.
La schiuma legata a sorgenti antropiche merita attenzione quando presenta:
- Aspetto: bianco molto brillante o grigiastro, talvolta con riflessi anomali; schiuma molto persistente, compatta, che resiste anche senza mare agitato.
- Odore: note chimiche, rancide o fognarie.
- Contesto: presenza di acque torbide, rifiuti, film superficiali oleosi, vicinanza a scarichi (fognari, industriali, agricoli) o aree portuali.
- Frequenza: ricorrenza in particolari punti, indipendentemente dalle condizioni meteo-marine.
In questi casi è possibile la presenza di tensioattivi sintetici (detergenti), idrocarburi/emulsioni, nutrienti (azoto/fosforo) che innescano fioriture anomale, o miscele complesse di sostanze.
Non è detto che vi sia sempre un rischio sanitario immediato, ma si tratta di un indicatore di pressione antropica che va approfondito.
Focus sulle fioriture microalgali (HAB): quando la schiuma è “biologica ma problematica”
Alcune fioriture (HAB, Harmful Algal Blooms) producono tappeti mucillaginosi o rilasciano composti irritanti; la schiuma che ne deriva, pur non essendo un detergente, può creare aerosol irritanti e fastidi alle vie respiratorie, specialmente con mare mosso e vento a riva. In questi casi è fondamentale affidarsi alle comunicazioni ufficiali delle autorità locali, che dispongono eventuali limitazioni temporanee all’uso ricreativo.
Come valutare rapidamente il fenomeno in spiaggia (protocollo operativo “light”)
Per chi opera sul territorio o vuole effettuare una osservazione documentata (bagnini, gestori, tecnici comunali, consulenti):
- Documentazione
Annota data, ora, posizione (GPS se possibile), condizioni meteo-marine (vento, stato del mare, marea), temperatura aria/acqua. Scatta foto panoramiche e di dettaglio. - Osservazioni qualitative
Valuta colore, odore, consistenza, estensione, persistenza, eventuale associazione con rifiuti o film oleosi, presenza di corsi d’acqua o scarichi nelle vicinanze. - Campionamento di base (se attrezzati)
Preleva in contenitore pulito (meglio vetro) evitando contaminazioni. Se disponibile, esegui in campo pH, conduttività, torbidità; conserva il campione refrigerato per analisi di laboratorio. - Segnalazione
In presenza di schiume anomale e persistenti, contatta l’ARPA competente per territorio o l’ufficio comunale ambiente. Le agenzie dispongono di protocolli per attivare campionamenti mirati.
Indagini di laboratorio utili (quando si sospetta un contributo antropico)
Quando le autorità o i tecnici avviano un approfondimento, i pacchetti analitici possono includere, oltre ai consueti parametri di balneazione:
- Tensioattivi: anionici (MBAS), cationici (ad es. composti di ammonio quaternario), non ionici.
- Indicatori di carico organico: COD, BOD, TOC, pigmenti (clorofilla-a) e DOM/FDOM per la frazione organica disciolta.
- Nutrienti: azoto (NH₄⁺, NO₂⁻, NO₃⁻) e fosforo (PO₄³⁻), per valutare pressioni eutrofiche.
- Idrocarburi e prodotti petroliferi in caso di film superficiali oleosi.
- Microbiologia (parametri di balneazione) per escludere concomitanti criticità igienico-sanitarie.
L’interpretazione integrata dei risultati (chimica + biologica + contesto) è essenziale per distinguere fra cause interamente naturali, prevalentemente antropiche, o miste.
Quadro normativo essenziale (Italia/UE)
La qualità delle acque di balneazione è regolata in Italia dal D.Lgs. 116/2008 che recepisce la Direttiva 2006/7/CE. Il sistema prevede:
- Monitoraggi periodici da parte delle ARPA regionali con classificazione delle acque e pubblicazione dei risultati.
- Valutazioni anche visive: schiume, colorazioni anomale, rifiuti galleggianti e fenomeni che possano indicare pressioni esterne.
- In caso di criticità, campionamenti straordinari, informazione al pubblico e, se necessario, misure temporanee (divieti, raccomandazioni).
Per i fenomeni microalgali (HAB) e le acque di ricreazione, si fa riferimento anche a linee guida tecniche nazionali e internazionali (es. indicazioni OMS sulle acque ricreative), utilizzate dalle agenzie per contestualizzare i rischi e modulare la comunicazione ai bagnanti.
Come comportarsi come bagnanti, gestori e amministrazioni
Sebbene la schiuma naturale non sia generalmente pericolosa, è prudente:
- Evitare il contatto prolungato con schiume dall’odore sgradevole o dall’aspetto anomalo e segnalare il fenomeno alle autorità.
- Per i gestori di spiagge: affiggere avvisi temporanei quando è in corso una verifica; informare i bagnanti con messaggi semplici e aggiornati.
- Per i Comuni: attivare rapidamente ARPA in caso di ricorrenza/persistenza; controllare eventuali scarichi o apporti fluviali a monte; curare la comunicazione trasparente.
Domande frequenti (FAQ)
La schiuma naturale è tossica?
Di norma no. È un indicatore di tanta materia organica naturale e moto ondoso. Può però risultare sgradevole al tatto e all’olfatto quando molto concentrata.
Perché a volte è beige o brunastra?
Perché ingloba materiale organico e pigmenti algali. Il colore non implica automaticamente inquinamento.
Se sento odore “di detersivo” o “di fogna”?
È un segnale di allerta. Evita il contatto, segnala subito alle autorità e attendi comunicazioni ufficiali.
Perché la schiuma appare dopo giorni di mare mosso?
Le burrasche frammentano e rimescolano masse d’acqua ricche di organico; quando il mare si calma, la schiuma può accumularsi lungo linee di convergenza o sulla battigia.
Conclusioni “operative”
I puntini bianchi persistenti che evolvono in schiuma sono spesso il volto visibile di processi naturali: alta produttività biologica e mare agitato.
§Tuttavia, in presenza di odori anomali, persistenza eccessiva, riflessi innaturali o contesto compromesso, la schiuma può essere un campanello d’allarme di origine antropica.
L’approccio corretto è osservare, documentare e – se necessario – segnalare, affidandosi alle ARPA per campionamenti e verifiche.
Così tuteliamo l’ambiente marino, la sicurezza dei bagnanti e la qualità della nostra esperienza in spiaggia.
Nota divulgativa (per il lettore non tecnico)
La prossima volta che vedi quei “puntini bianchi” diventare schiuma, sappi che in molti casi stai guardando la chimica e la biologia del mare al lavoro.
Se l’odore è neutro e l’aspetto è “marino”, è probabile che sia naturale.
Se invece la schiuma è molto persistente, dall’odore sgradevole o associata a sporcizia, meglio evitare il contatto e segnalare: potrebbe esserci un apporto esterno che le autorità devono verificare.
Foto 1) Schiuma naturale in mare (fenomeno biologico, innocuo)

Foto 2) Schiuma da inquinamento (tensioattivi e scarichi)